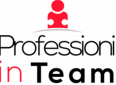«Papà fu un avvocato e vittima della mafia, non suo complice»
Lo sfogo di Flavia Famà, figlia di Serafino, penalista ucciso dalla mafia nel 1995. «Le parole del Fatto Quotidiano sugli avvocati sono indegne: sono necessarie delle scuse»
In evidenza

«L’avvocato è giusto che in aula porti la toga. L’avvocato è giusto che dica al pubblico ministero che deve occupare il posto che il codice prevede non sieda accanto al giudice. L’avvocato è giusto che nell’ambito delle sue funzioni sistematicamente stia attento a che i suoi diritti non vengano disconosciuti. (…) Io mi sono sistematicamente rifiutato di accettare la perquisizione a Bicocca perché la trovo indegna. Trovo indegno il fatto che il poliziotto acquisti la mentalità e la cultura che l’avvocato è istituzionalmente soggetto meritevole di sospetto. È questo il fatto che mi indigna non la perdita di tempo di tre minuti». Era il 1994 quando Serafino Famà, penalista di Catania ucciso dalla mafia il 9 novembre dell’anno dopo con sei colpi di pistola calibro 7,65, pronunciava queste parole. Si trovava ad un’assemblea della Camera penale, in adesione allo sciopero dei colleghi di Napoli, dove denunciò la «sistematica arrendevolezza degli avvocati di fronte ai loro diritti». Di fronte a chi, ad esempio, considera il diritto alla difesa un’onta che estende i “peccati” degli assistiti ai propri difensori. Un pregiudizio, ci racconta oggi Flavia Famà, figlia di quella vittima di mafia, che di fronte all’ennesimo attacco lanciato dal Fatto Quotidiano contro la professione forense ha risposto indignata, ricordando il sacrificio non solo di suo padre, ma anche di Fulvio Croce e Giorgio Ambrosoli.
«Non ci sono vittime di mafia di serie A e vittime di serie B», sottolinea, sorpresa di dover evidenziare l’ovvio di fronte al sistematico attacco ai diritti. Dalla propria pagina Facebook, Famà ha definito «indegne» le parole del quotidiano diretto da Marco Travaglio, secondo cui la sentenza della Consulta che cancella la censura della corrispondenza tra detenuti al 41 bis e avvocati rappresenterebbe l’opportunità, per i boss mafiosi, di “commissionare” omicidi e stragi tramite i propri difensori. «Mio padre si ribellava a questo genere di insinuazioni infamanti che peraltro gettano discredito su tutta la categoria – sottolinea -. Da figlia di un avvocato ammazzato dalla mafia proprio perché svolgeva in modo corretto la professione di difensore mi sento offesa e amareggiata». Affermazioni sbagliate, racconta oggi al Dubbio, al netto della libertà di pensiero e di espressione. «Ricordiamoci che, in teoria, le conversazioni degli avvocati non possono essere intercettate, quindi non vedo perché debbano poterlo essere quelle con un assistito che si trova al 41 bis, solo perché si dà per scontato che sia complice di eventuali reati», afferma. Una cosa intollerabile per chi, «come me, ha vissuto sulla propria pelle un’esperienza del genere – racconta -. Molte volte mi sono ritrovata a dover giustificare quello che è successo a mio padre per il solo fatto di essere un avvocato penalista, come se solo per questo lui fosse colpevole di qualcosa. Come se se la fosse cercata, come molte volte mi sono sentita dire. Questo tipo di giornalismo arreca tantissimo danno, soprattutto nella settimana dedicata agli avvocati in pericolo: sembra una presa in giro. Però quando questi giornalisti così giustizialisti vengono querelati si rivolgono agli avvocati e li cercano altrettanto liberi e altrettanto integerrimi di quelli che in realtà stanno infangando».
Il problema è come sempre uno: identificare il difensore con il proprio assistito ed estendere il reato anche a chi è chiamato a garantire la difesa dei diritti. «Ci si dimentica che la difesa è tecnica, è garantita dalla nostra Costituzione ed è il baluardo della democrazia – spiega -. Senza avvocati a far valere i diritti è un attimo che si trasformi in una dittatura». Famà, come il padre, è appassionata di diritto e si occupa di America Latina. Ed è proprio lì che va il pensiero, cogliendo al volo l’occasione della giornata dedicata agli avvocati in pericolo nel mondo. «In Colombia chiunque non la pensi come il governo è considerato un terrorista e gli avvocati che assistono le vittime di Stato sono considerati allo stesso modo – ha evidenziato -. Ovviamente in Italia non siamo a questi livelli in termini di ritorsioni e pericolosità, ma con una magistratura che sembra concedere un favore quando consente all’avvocato di garantire il diritto di difesa, colleghi arrendevoli davanti ai propri diritti, come li definiva mio padre, e un giornalismo superficiale e meschino, il passo è breve: non ci vuole molte a perdere quel minimo di democrazia che c’è».
Famà venne ucciso per aver detto di no alla richiesta avanzata dal boss Di Giacomo, che pretendeva di far testimoniare al processo una donna, sua cognata e amante, nonché moglie di un pentito, che non ne aveva alcuna intenzione. «Quando leggo cose del genere, scritte da chi magari si straccia le vesti il 23 maggio e il 19 luglio, penso: mio padre non ha contato niente? Delle due l’una: non si possono distinguere le vittime di mafia. Essere avvocato non significa automaticamente non essere onesto. Non voglio scuse in memoria di chi è morto, ma in nome di tutti gli avvocati onesti che sono ancora in vita». L’avvocato, spiega, è come un medico: «Non si può scegliere se operare o meno in base al fatto che il paziente sia una brava o una cattiva persona. L’avvocato fa il proprio mestiere con solitudine e fatica e la consapevolezza che le proprie azioni possono avere conseguenze in termini di libertà personale». E per spiegare chi fosse realmente suo padre racconta un episodio: «Ci fu un processo terribile, in cui fece un’arringa lunghissima, al termine della quale il giudice voleva ritirarsi e decidere alla fine della giornata. Ma, codice alla mano, mio padre disse che andava fatto subito. Il giudice fece così, perché era previsto, e condannò l’imputato – conclude -. I colleghi di studio gli dissero: “Avvocato, ma sempre tu! Ti sei impuntato e abbiamo perso la causa”. Ma lui rispose che aveva vinto, perché aveva fatto rispettare le norme. Un avvocato non sente di aver vinto se il pluriomicida è libero di commettere reati, ma se ha garantito il rispetto del giusto processo. È questo che certi giornalisti dovrebbero ricordare».
Altre Notizie della sezione

Responsabilità genitoriale, la Consulta: decide il giudice caso per caso
23 Aprile 2025Niente sospensione automatica in caso di condanna per maltrattamenti.

Trump strozza pure il mondo degli avvocati
22 Aprile 2025Così la professione legale si piega al potere.

Nordio incontra Anm “Sintonia e confronto su temi concreti”
16 Aprile 2025“È stata l’occasione per un confronto aperto e franco sui temi concreti delle giurisdizione”.